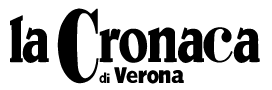Il mondo si divide tra chi ascolta Vasco e non teme di dichiararlo e chi lo ascolta o lo ha ascoltato, ma non lo ammetterebbe mai. Non so se ci avete mai fatto caso, ma risulta sempre divisivo. Siete a una cena con amici e conoscenti (un tempo succedeva), si parla di musica, di concerti indimenticabili e voi ve ne uscite dicendo “come Stupido Hotel del 2001, nient’altro mai”. In un attimo i commensali sono tutti lì, senza parole, a guardarvi impietriti, come se aveste appena detto “non sento i sapori”.
Accade poi che qualcuno si prodighi pure in una lectio magistralis sul perché dire che si ama Vasco sia disdicevole. Le accuse che gli vengono mosse sono di solito principalmente due. L’aver perso la forza dirompente degli esordi, finendo a riproporre l’identico in un eterno ritorno, e l’essersi reso colpevole di imperdonabili cadute di stile nel corso della sua carriera.
Ma c’è poi l’accusa diretta anche a te, poveretto, che hai ammesso che Vasco ti piace. La sola ammissione cambia la percezione che la gente ha di te. Immediatamente già ti vedono: una bandana in testa, l’ascella pezzata e una birra calda in mano, sul prato di un qualche stadio ad urlare “eh già”. Perché diciamolo, questa è l’idea: non puoi essere fan di Vasco senza essere un fanatico. Non è vero. E se ammettiamo ad esempio, ripescando in un qualche passato, un certo senso di straniamento al Bentegodi nel pomeriggio di attesa, mentre si sopravviveva tra getti di birra, urla di donne con improbabili sopracciglia e spintoni di ragazzi in tenuta d’ordinanza (la bandana, una canotta, jeans tagliati a mezza gamba, converse), dobbiamo anche riconoscere la scomparsa di quello stesso straniamento, quando ore dopo ci si trovava a cantare a squarciagola “sì stupendo, mi viene il vomito” assieme ad uno stadio intero. “Il popolo di Vasco” direbbe quello della lectio magistralis. Eh già.
Nato il 7 febbraio del ’52 a Zocca, provincia di Modena, Vasco Rossi, per tutti Vasco, è stato il primo vero rocker italiano. Anzi per dirla con le parole di De Andrè “l’unico credibile nel ruolo di rocker in Italia. L’unico ad essere riuscito a portare la canzone d’autore nel rock”. Fabrizio era legato a Vasco da un’amicizia sincera e profonda. Lo conobbe nell’84, quando con l’allora compagna Dori Ghezzi, gli fece visita presso il carcere di Rocca Costanza a Pesaro dove Vasco era rinchiuso per detenzione di sostanze stupefacenti. Furono gli unici due ad andare a trovarlo. Vasco aveva già alle spalle due partecipazioni a Sanremo, nell’82 con “Vado al massimo” e nell’83 con “Vita spericolata” e sei album.
Era già affermato. A contraddistinguerlo era soprattutto una freschezza comunicativa dirompente che gli permetteva di ironizzare sulla leva obbligatoria (faccio il militare), di parlare di sesso in maniera sfrontata come pochi altri si permettevano di fare, sdoganando al contempo l’impaccio e il senso di inadeguatezza (Io non so più cosa fare), di citare i Sex Pistols (Fegato, fegato spappolato) e di fregarsene di qualsiasi forma ci fosse di “politicamente corretto”.
Cantava se stesso, nel bene e nel male, e siccome era vero, in maniera talmente onesta da rasentare l’autolesionismo, la gente in lui si identificava. O al contrario lo disprezzava. “Ascoltando De Andrè ho capito che si potevano dire le cose con un’ironia feroce. Non tutti capivano che le mie canzoni sono sempre state provocatorie e ironiche. Scrivevo ‘vado al massimo’ nel periodo più brutto della mia vita”.
E con questo suo essere provocatorio e ironico, sincero e non consolatorio, Vasco ha attraversato decenni di musica italiana, i primissimi anni ‘80 ancora imbevuti di libertà e sperimentalismo espressivo, gli anni ‘90 così densi di conformismo e correttezza ai limiti dell’ipocrisia, per approdare al nuovo millennio ritrovando se stesso in un tempo nuovo, sempre in equilibrio sopra la follia.
Dal “Paroliere” per la canzone Ogni volta nel 1982, alla Targa Tenco per il miglior album nel 1998 con Canzoni per me, il Premio Lunezia in qualità di Poeta del Rock per la canzone Quanti anni hai nel 1999, il Nastro d’argento alla migliore canzone originale per Un senso e di nuovo il Tenco, questa volta alla carriera, nel 2020.
Vasco, di sé, ha cantato tutto, senza tacere gli aspetti più impietosi. Non ha celato il senso di esclusione, l’inadeguatezza mascherata da superbia, la goliardia e il disincanto assieme alla tenerezza più profonda. E così se è vero che gli si perdonano canzoni minori, la cui cifra artistica probabilmente sta solo nel fatto che le abbia scritte lui, non si possono negare le vette (tante, troppe per essere un caso) di poesia e verità che suonano come vere e proprie epifanie. Se vi siete mai portati appresso un cuore in frantumi, allora non potete negare quanto quella disperazione trovi la sua espressione compiuta in queste poche parole: “Tutto mi sembra inutile/Tutto mi sembra com’è/Telefonarti o uccidere/Che differenza c’è”.
Da “La nostra relazione” all’ultimo singolo “Una canzone d’amore buttata via”, passando per “Le cose che non dici”, “Mi si escludeva”, “Non l’hai mica capito”, “Sally”, “Stupendo” non ha smesso di raccontarsi, con il tono spericolato, i pensieri tutti, anche quelli storti. Perché è anche dalle cose scomode, da quelle sbagliate che a volte viene fuori il meglio. Come uno che “se esistesse la pillola contro i sensi di colpa la prenderei subito, ma alla fine rifarei tutto: stessi errori, stesse passioni, stesse delusioni”. Nonostante questo o proprio per questo Vasco è stato e rimane tutt’oggi divisivo. Provate a farne il nome a una cena, così a sorpresa e scatenerete una diatriba degna di un film francese. Succede sempre. Direi ogni volta.
Giulia Tomelleri