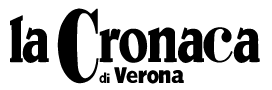Geppetto è un anziano falegname che a stento riesce a vivere del suo lavoro. Quando in città arriva un teatro di burattini di legno, Geppetto decide di costruirne uno tutto per sé, con il quale mettere su uno spettacolo e girare il mondo. Nel ceppo fornitogli da Mastro Ciliegia si nasconde però un segreto: appena scolpito in forma di bambino il burattino prende vita, trascinando l’anziano falegname in un’incredibile avventura. Se c’è un regista in Italia capace di mescolare fino alla perfetta fusione il registro fantastico con quello realistico quello è Matteo Garrone: se in Dogman abbiamo visto il suo sguardo incarnarsi nel volto malinconico e indurito di Marcello Fonte e in Racconto dei racconti l’elemento fiabesco mostrava il rovescio della medaglia in un’atmosfera orrorifica, con Pinocchio il regista trova un punto di equilibrio tra queste due tensioni, valorizzando il racconto nella sua forma più visionaria, senza però mai dimenticare un viscerale attaccamento al valore storico, materiale e sociale del paesaggio e dei suoi abitanti. Si tratta sicuramente di voler dare nuova veste a un capolavoro appartenente alla tradizione letteraria, ma la dedizione che Garrone dimostra raccontando questa storia immortale ci parla soprattutto di un profondo affetto per l’italianità: spazio umano e paesaggistico da riscoprire, che trova all’interno e oltre l’opera di Collodi orizzonti nuovi e sorprendenti; per questa ragione il rispetto della scrittura verso la linea narrativa del romanzo non può essere ridotto a una pura volontà deferenziale: le avventure più importanti che Pinocchio vive nel libro sono in effetti perfettamente replicate nel film, ma non è nel nucleo dell’azione che si trova la vera identità dell’opera, quanto in quello che i protagonisti non fanno o in ciò che non riescono ad essere fino in fondo di fronte alle sfide della storia. In tal senso Garrone preferisce infatti inabissarsi nelle paludi degli ultimi, facendoli diventare il simbolo di una italianissima popolazione di poveri in lotta per la sopravvivenza; con caratteri-tipo come Geppetto, il Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe il film riesce dunque a dar vita a tutte le sfumature dell’umano, sfociando volentieri in toni incubici e perturbanti degni di un Edgar Allan Poe. Oltre e dentro tutto questo c’è il personaggio di Pinocchio, portabandiera del diverso per eccellenza perché non-uomo, eppure in cerca di un’umanità risolutiva e ultima. È infatti nella sua crescita emotiva ed esistenziale che si trova il vero centro del film: le marachelle e il naso lungo contano poco, la rinuncia di sé, della propria durezza materiale e caratteriale – che è poi quella dell’infante, fermo nelle sue posizioni di necessità – è il punto più alto e faticoso di quel desiderio d’umano che lo anima. Raggiungerlo vorrà dire puntellare sé stesso, imparare a conoscersi e infine educarsi al sacrificio e alla fatica: non tanto per guadagnarsi un posto rispettabile nella società, ma per prepararsi a ricevere quell’amore paterno attraverso cui si può arrivare ad essere finalmente uomini.
Maria Letizia Cilea