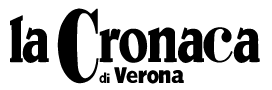Metà degli anni ’80. Fabietto Schisa è un sedicenne timido e riflessivo con una colorata famiglia allargata in quel di Napoli. Ognuno di loro si nutre di storie, amori, dolori celati e speranze, che muovono la loro vita e danno significato alla quotidianità. Unico comune denominatore: l’attesa per l’arrivo di Maradona al Napoli, evento storico su cui si vocifera da mesi, di cui nessuno però ha ancora avuto conferma. Tutto scorre con un ritmo fatto di semplicità e amore, ma quando un evento drammatico segna la famiglia Schisa, Fabietto diventa insofferente nei confronti di una realtà che non gli piace più.
Dopo aver esplorato la fauna romana della devastata vita alto borghese con gli strumenti dell’arte felliniana ne La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino aggiunge un altro punto luminoso alla sua filmografia dedicandosi a una storia personale e sentitissima – la sua – e alla città che lo ha plasmato in tutto e per tutto: Napoli.
Se è vero che tra Napoli e Roma c’è un abisso di differenze culturali, linguistiche e sociali, allo stesso modo È stata la mano di Dio esprime il polo affettivo e umano per il regista partenopeo, dove La Grande Bellezza incarnava la sua natura estetica ed intellettuale da cineasta erede di Fellini.
Il film rappresenta dunque un punto di svolta nella sua carriera, e non solo perché Sorrentino si concede un intimismo inaudito, ma anche perché quella stessa verve autobiografica valorizza persino la sua componente formale, che qui ci guadagna in autenticità.
Già maestro dell’immagine, qui l’autore riesce infatti a modulare meglio il suo barocchismo e raramente eccede in iperboli narrative o scene ai limiti dell’onirismo; il sogno ci entra comunque, ma per la via maestra dell’autobiografismo: non più l’assurdo al centro, ma il racconto di ciò che lo ha portato a nutrire una passione per una realtà alternativa, che è poi quella che viviamo nelle due ore di proiezione, seduti al buio nel nostro personale sogno cinematografico.
È un bel sogno, quello che Sorrentino ci racconta, finalmente libero da quel cinismo tipico delle sue opere precedenti e forse proprio per questo più aderente alla semplice complessità della vita reale; una vita nella quale si passa dal ridere – a crepapelle, per delle scene famigliari al limite del genio – al commuoversi, arrivando persino a provare una famigliarità e un senso di condivisione identici a quelli dei personaggi sullo schermo.
La parata di figure umane è poi incarnata da un cast corale azzeccatissimo, che trova il suo punto più alto in Toni Servillo, aka Saverio Schisa, padre di Fabietto e uomo dalle mille sfaccettature. Oltre alla storia, sfaccettata è anche la Napoli raccontata da Sorrentino, che si sofferma sulle case napoletane, sugli arredamenti, sulle tavolate di famiglia, sui pentoloni di sugo di pomodoro e su infiniti altri dettagli, narrati con evidente affetto per un mondo lontano, che un tempo a Sorrentino sarà pure sembrato «scadente», per citare Fellini, ma che è ora diventato serbatoio prezioso dal quale pescare la storia più bella che il regista ci ha raccontato finora.
VOTO: 9.5