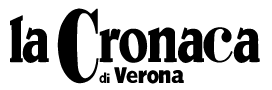Poi entrò lei. Una bambina. Aveva 14 anni. E stupì il mondo. Si chiamava Nadia. Rumena. Leggera. Graziosa. Volava. I giudici la seguirono, non avevano mai visto niente di simile. Si guardarono come a dire, “ma questa, da dove viene?”.
Poi lei “atterrò” sul tappeto. Leggerissima. Le braccia “stirate”, nel passo finale. Il sorriso stampato sul viso, “esci sempre col sorriso” le avevano raccomandato gli insegnanti. Qualche giudice non riuscì a trattenersi. E applaudì. Il problema arrivò più tardi. Quando i giudici decisero il voto e il tabellone non lo prevedeva. “Come facciamo?”, si chiesero.
Il tabellone arrivava fino a 9,99, mai visto un 10 nelle gare di ginnastica. Mai, prima di Nadia Comaneci. Il voto tardava, lei si sentiva dentro un’ansia strana. “Perchè?”, chiese al suo maestro. Lui prese tempo. Lo presero anche i giudici. Poi decisero. E fu un boato nello stadio di Montreal. Il tabellone indicò un 1,00, voleva dire 10, come annunciò lo speaker. Nadia saltellò felice tra le braccia del suo allenatore.
La tristezza arrivò più tardi. Anni dopo. Quando pagò quel prezzo. Altissimo. Ne fecero un simbolo del comunismo, l’icona della Romania felice (felice?) del dittatore Ceausescu. Lui le impose di diventare l’amante di suo figlio Niko, ubriacone violento. Lei subì. Vinse altre medaglie d’oro per il regime. Passò da un dolore all’altro, tentò pure il suicidio. Poi trovò (finalmente) pace. Andò negli Stati Uniti, sposò un americano conosciuto anni prima. Diventò mamma. Rimase un simbolo. Di quello che lo sport può essere. Di quello che la vita non dovrebbe mai diventare.