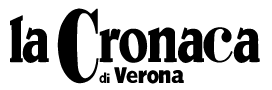Si è tenuta al Cinema Teatro Aurora di Verona la proiezione di Io resto, documentario realizzato dal regista veronese Michele Aiello durante la prima ondata pandemica dentro gli Spedali Civici di Brescia.
Nella tua filmografia esplori una grande varietà di temi. Come scegli le tue storie?
Credo dipenda un po’ dai percorsi che imbocchi mentre lavori su qualcosa. Io ho sempre avuto un interesse verso attualità, questioni politiche e sociali: quando leggo una notizia che mi attira la approfondisco e poi valuto se perseverare nella ricerca. Non tutte le storie che mi interessano si sono trasformate in film, però molte mi sono state utili per trovare dei contesti che mi hanno aiutato a raccontare ciò che mi interessa: l’aspetto umano.
Ci racconti di te e di come è nata questa tua passione?
Sin dal liceo ho avuto il pallino di fare il giornalista. All’università ho studiato Relazioni Internazionali, poi ho frequentato la scuola Basso per giornalismo a Roma; la precarietà del mondo giornalistico, però, mi ha frenato: ho provato a lavorare da freelance con qualche inchiesta, poi ho iniziato a fare laboratori di video partecipativo e a lavorare come co-autore di documentari. Il documentario mi ha coinvolto di più al livello personale e mi ha dato più soddisfazione al livello economico: ho imparato che, a volte, è più interessante lavorare con una prospettiva più personale piuttosto che focalizzarsi sulla notizia di attualità. Così è stato con Io resto, il documentario nel quale ho provato a raccontare la prima fase della pandemia.
Come avete gestito le fasi realizzative del documentario Io resto?
Lo abbiamo realizzato a quattro mani: ho chiesto al direttore della fotografia Luca Gennari di venire in Lombardia, dove mi era stato concesso l’accesso a un ospedale. Una volta dentro ho sentito molto opprimente il senso di responsabilità: era un’occasione straordinaria, dovevamo fare un bel lavoro. Il fatto che non fossimo più nelle fasi più frenetiche ci ha permesso di indagare le relazioni umane piuttosto che l’emergenza in sé. Ovviamente, non abbiamo avuto tempo di fare sopralluoghi: filmavamo tutto ciò che succedeva, e pian piano abbiamo deciso di seguire coloro che ci sembravamo più potenti dal punto di vista comunicativo, anche al di là della gestione specifica della malattia in reparto.
Ti occupi anche di laboratori audiovisivi nelle scuole. Secondo te, cosa può insegnare il cinema alle giovani generazioni?
Viviamo in un mondo in cui sempre più guardiamo per capire ciò che c’è intorno a noi. L’educazione all’immagine dovrebbe quindi essere pane quotidiano per i ragazzi, perché loro sono molto allenati a guardare ma non ad analizzare. Lavorare coi ragazzi da poi una grande soddisfazione, perché la loro capacità creativa permette di accedere anche a sguardi sperimentali e a nuovi linguaggi. Io cerco sempre di far emergere la visione dei ragazzi, non voglio imporre la mia visione. Così vengono fuori suggestioni interessanti, sguardi sul mondo che sono artistici nel senso più profondo del termine.
Martina Bazzanella
Maria Letizia Cilea