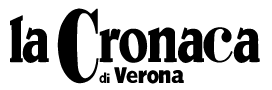No, non ce la può fare. Tu guardi oggi gli ultimi 50 metri dei 200 di Mosca, Olimpiadi ‘80, e dici, “Mennea non ce la fa, è impossibile”.
Prova a riguardarli, vai su You tube e seleziona “Mennea, 200 metri a Mosca”.
“Ma no, non si può”. No, c’è qualcosa di disumano, in quel finale. C’è tutto quello che puoi chiedere a un’emozione. C’è il gusto dell’impossibile, il fascino di un’impresa che entra nella storia senza passare dalla cronaca.
“Ma va’, non ce la fa”. No, sono cose da favola, ma lì siamo alle Olimpiadi, ne ha almeno tre, forse quattro, davanti. Ne aveva cinque o sei, quando era entrato in rettilineo. Prova a rivedere, schiaccia “replay”, vedi quando entra ai 100 metri, dov’è Pietro Mennea. Forse ultimo, addiritura. E ai 30 metri è ancora giù dal podio. E sembra pure stanco, “cacchio, che gli sta succedendo?”.
Poi, però, guardalo bene e preparati. Perchè, anche se l’hai già visto e rivisto, quel finale lì è roba da cuori forti. Lo vedi, quando lo pensi stanco e battuto, demoralizzato e depresso, eccolo tutto l’orgoglio del ragazzo del sud. Allora il viso è solo una smorfia tirata, una maschera di musocli e nervi, orgoglio e sacrifici, cuore e carattere. Allora le gambe vanno via come il vento, leggere, forti, il ritmo è più intenso, le braccia lo spingono, lui sembra volare e gli altri, improvvisamente, ti sembrano fermi.
“No, non può farcela”. Ancora 10 metri, davanti c’è solo Alan Wells, l’inglese, “va bene anche l’argento”. No, Pietro accelera ancora, si getta sul filo, ha già capito tutto. Ha vinto. Ha l’oro. Ha una maschera di felicità. 200 metri senza fine