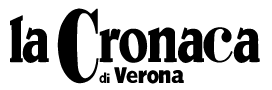Quando, a seguito del processo condotto in Israele tra il 1960 e il 1962 contro Adolf Eichmann, sfuggito a Norimberga, rifugiatosi in Argentina e lì individuato dal Mossad – l’istituto di intelligence israeliano –, Hannah Arendt pubblicò uno dei suoi libri più celebri, La banalità del male, le reazioni furono varie.
Molti furono coloro che contestarono la definizione, divenuta poi canonica, che dà il titolo al libro – formalmente, un reportage ragionato degli atti processuali.
A seguito degli orrori perpetrati da nazisti nei campi di concentramento e di sterminio, che costarono la vita a dieci milioni di persone tra omosessuali, rom, oppositori politici, comunisti, ebrei e altre categorie, pareva inconcepibile il tentativo, avvertito come tale, di giustificare le azioni condotte da gerarchi e soldati tedeschi.
La reazione, certamente comprensibile, non centrava però il punto del ragionamento di Arendt, che non intendeva banalizzare gli esiti di quelle azioni, bensì mostrare come a essere banali fossero i loro moventi e il coinvolgimento emotivo dei loro attori.
L’espressione più ricorrente pronunciata da Eichmann durante il processo è la nota frase: «ho solo eseguito degli ordini». Questa giustificazione, sentita come pienamente tale da Eichmann ma che non giustifica assolutamente nulla, dimostra precisamente il carattere principale della banalità del male: la persona agente viene essa stessa de-umanizzata, perde qualsiasi consapevolezza morale delle azioni che compie, inserisce se stessa all’interno di una macchina organizzativa quasi perfetta ed efficientissima, quale era quella nazista.
Con l’espressione banalità del male, poi, Arendt intendeva mettere in luce anche un ulteriore aspetto: i gerarchi nazisti non erano “geni del male”, “demoni”, “mostri”; erano persone comuni, come tante ce ne sono, mediocri nel senso letterale, ossia che si collocano, agli occhi di Arendt, nella zona grigia della società, né straordinari né pessimi.
In questo senso il male è “banale”: perché, letto in quest’ottica, è potenzialmente molto diffuso, latente nella personalità. Con questo, Arendt non intendeva certo suggerire che tutti gli uomini siano mostri in potenza; voleva mettere in luce, al contrario, la necessità di costruire un senso morale che mantenesse la responsabilità della persona e permettesse di cogliere il valore dell’azione compiuta, anche se essa proviene da un ordine esterno o, come accadeva nel caso degli alti quadri dirigenti nazisti, se non se ne vedono direttamente gli effetti. Da questo punto di vista, anche più interessante del libro di Arendt, in quanto memoria scritta di proprio pugno da un gerarca nazista e quindi ancor più crudamente diretto nella sua “banalità”, è il libro Comandante ad Auschwitz di Rudolf Höss, la cui lettura è consigliata a chi voglia gettare uno sguardo nel pensiero quotidiano e “mediocre” di un agente della morte.
Effeemme