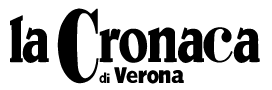Visto il periodo Pasquale che stiamo vivendo, ho pensato in questo articolo di occuparmi di una bellissima opera: il crocifisso di Lorenzo Veneziano che si trova nella basilica di San Zeno maggiore restaurato poco tempo fa. Lorenzo Veneziano, fu uno dei primi seguaci di Paolo Veneziano, alle origini della scuola veneziana. Inizialmente era legato allo stile bizantino seguendo in seguito il gotico boemo e mostrandosi più attento ai dettagli naturalistici, fino ad arrivare alle soglie dello stile del gotico internazionale e diventando uno degli artisti veneziani più importanti della sua epoca. Rispetto all’arte bizantina, già nel gotico si ravvisa un processo di trasformazione, caratterizzato da una crescente drammatizzazione della figura di Cristo, che giungerà alla piena e drammatica umanizzazione del mistero della morte di Cristo in piena devozione francescana. Tuttavia, laddove nell’arte occidentale si assiste alla trasformazione dall’immagine del Cristo trionfante sulla morte, all’immagine del Cristo dolente (Christus patiens), ritratto realistico della sofferenza terrena, che lascia a mano a mano scomparire l’ieraticità distaccata di matrice alto medioevale, nell’arte orientale il corpo del Cristo morto non mostra mai segni di corruzione, sembra addormentato, ed è bello anche nella morte che non può alterare la carne incorruttibile del Salvatore. La Croce di Lorenzo Veneziano è stata dipinta intorno al 1356/59 su fondo oro e decorata da un’elegante anche se lacunosa cornice fogliacea e mostra al centro la raffigurazione di Cristo morto e, al limite dei due assi, quattro medaglioni trilobati. Nel medaglione in alto compare Dio Padre che invia la colomba dello Spirito Santo; ai lati dell’asse orizzontale sono dipinti, addolorati, i testimoni della Crocifissione, la Madonna e il discepolo prediletto, che la tradizione indica in San Giovanni Evangelista; nella parte bassa dell’asse verticale è inserita una rappresentazione del Golgota con il teschio di Adamo ( poiché Cristo ora è il nuovo Adamo da cui attraverso la morte e la Resurrezione parte la nuova creazione) mentre, in scala minore, sono inginocchiati due offerenti. L’uno è ritratto in vesti laicali mentre l’altro è riconoscibile come un frate domenicano dall’abito e dalla tonsura. Proprio presenza del frate dipinto ha fatto ipotizzare la provenienza dell’opera dalla chiesa veronese dei domenicani, che era Santa Anastasia antica stazione per le celebrazioni della domenica di Pasqua che ancora custodisce una tela dello stesso artista (la Madonna dell’umiltà nella cappella del Rosario). Il dipinto pur mostrando i segni di una pittura più evoluta soprattutto nel senso della simbologia, utilizza il fondo oro tipico della pittura bizantina. Usato nei mosaici fin dall’epoca paleocristiana, se ne hanno le prime tracce appunto in pittura nell’area bizantina. Venne ripreso in Italia con esempi databili già dal XII secolo. L’oro forniva un “colore”estremamente luminoso e astratto, che era particolarmente apprezzato nei soggetti sacri per l’effetto mistico. Inoltre aveva uno scopo prettamente devozionale: l’alto costo del materiale era visto come un’offerta alla divinità, che poteva ripagare per alcuni peccati commessi, soprattutto quello di usura.
Tiziano Brusco