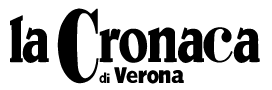Non tutti gli uomini sognano allo stesso modo. C’è chi sogna solo la notte e chi lo fa di giorno ma in maniera poco convinta, come se nella vita a contare fossero solo il pragmatismo o l’aderenza a una certa idea di sé e non, di contro, i desideri. E poi c’è chi invece sogna in grande. Sogna per sé ma anche per chi non ha gli strumenti per farlo e sogna con una tale potenza visionaria da rendere visibile il proprio sogno anche a chi gli sta accanto. Martin Luther King era un sognatore, ma uno di quelli convinti. Uno capace di sognare per un’intera nazione, uno che sapeva che le parole contano, eccome se contano. Se doveva parlare al popolo del “sogno americano”, era proprio da un sogno che doveva partire.
28 agosto 1963. Giorno della marcia di Washington per il lavoro e la libertà. Centinaia di migliaia di persone di ogni razza ed etnia avevano aderito alla manifestazione per chiedere l’approvazione di un disegno di legge significativo sui diritti civili, un salario minimo di 2 dollari, la fine della segregazione razziale nelle scuole, un programma di lavori pubblici federale, la protezione dalle brutalità della polizia per gli attivisti e il blocco delle pratiche di lavoro scorrette.
Il dispiegamento di forze dell’ordine era massiccio. Il presidente John Fitzgerald Kennedy temeva che la marcia potesse degenerare in una rivolta di proporzioni mai viste. Fu smentito dai fatti. E la marcia, del tutto pacifica, passò alla storia per quattro semplici parole: I have a dream. Io ho un sogno.
Davanti al Lincoln Memorial, di fronte a 250.000 persone, il reverendo Martin Luther King, a conclusione di questa marcia storica, pronunciò un discorso di 17 minuti scandendo per 8 volte, quasi in un canto, quelle 4 parole.
C’erano immagini potenti che toccavano le ferite di un intero paese, i nervi scoperti e la frustrazione di una comunità afroamericana vittima da sempre di discriminazioni istituzionalizzate. Ma anche oggi, ascoltando la voce di Martin Luther King nei video che lo ritraggono a Washington davanti alla folla in adorazione, non si può fare a meno di notare un ritmo, un tono, la cadenza da sermone e la determinazione nello scandire quelle quattro parole “io ho un sogno”. Le immagini di repertorio ci mostrano un King trionfante che – terminato il discorso – lascia il palco acclamato da una folla che guarda a lui come al leader morale della nazione.
Da quel momento in poi la lotta contro il razzismo e la segregazione razziale non sarà più la stessa. Accadono cose che fanno da spartiacque e dopo che sono accadute non è più possibile restare nella zona grigia, non prendere posizione. Diventa imperativo farlo. Ecco che cosa fu questo discorso. Ecco che cosa deve aver pensato Kennedy, quando guardando il video in diretta, disse di King ai suoi collaboratori “è dannatamente bravo”. Non a caso questo discorso resterà uno dei più famosi del ventesimo secolo, non a caso verrà analizzato da esperti di comunicazione, filosofi e sociologi e non a caso diventerà il simbolo della lotta contro il razzismo negli Stati Uniti.
Ma chi era Martin Luther King? Il reverendo Martin Luther King, pastore protestante, politico e soprattutto attivista, rappresentò una delle figure chiave del dopoguerra in Occidente. Da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti dei neri, delle minoranze e degli emarginati si distinse per l’adesione convinta ad una forma di resistenza pacifica, che gli varrà nel 1964 il Premio Nobel per la Pace. Il suo “sogno”, gridato ad una nazione che su un altro sogno – quello americano – aveva costruito o credeva di avere costruito le proprie basi, era appunto quello di una società americana libera, democratica, efficacemente ugualitaria, scevra da pregiudizi etnici e non.
Che cosa resta di quel sogno oggi? I have a dream today.
Nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca, nel 2009, il neoeletto Barack Obama, primo presidente afroamericano nella storia degli Stati Uniti, sembrò riprendere il filo delle parole di King. In un passaggio vibrante, celebrò infatti la bellezza della libertà e del sogno americano che permetteva ad un uomo il cui padre, meno di sessant’anni prima, avrebbe potuto avere difficoltà ad essere servito al tavolo di un ristorante, di pronunciare il solenne giuramento per la presidenza della nazione.
Ma gli 8 anni del duplice mandato di Obama hanno rappresentato per certi versi una illusione per la comunità afroamericana, nella misura in cui hanno fatto credere che una uguaglianza di diritti e soprattutto di opportunità e accesso a determinate posizioni potessero diventare effettivamente realtà.
Di fatto invece le ferite più profonde e il divario in termini di disoccupazione, reddito e istruzione non sono stati sanati nemmeno durante la sua amministrazione. Tanto che c’è chi non ha esitato a parlarne in termini di una “occasione mancata”. L’elezione di Trump poi, non ha fatto altro che portare allo scoperto in maniera impietosa il profondo divario che tutt’ora sussiste nella società americana, tra maggioranza bianca da un lato e minoranze dall’altra.
La questione razziale è riesplosa in questi mesi.
Dalla fine di maggio, gli Stati Uniti stanno attraversando un periodo di forti tensioni sociali: il video dell’omicidio di George Floyd, un afroamericano soffocato da un agente di polizia, ha portato alla luce una straziante serie di violazioni.
L’ultimo caso, quello del ventinovenne Jacob Blake, a cui la polizia ha sparato 7 colpi di pistola alla schiena, è accaduto solo il 24 agosto scorso. E a poco serve purtroppo, il moltiplicarsi di manifestazioni del movimento Black lives matter. Come scrive il critico e saggista americano Louis Menand, che in un recente articolo per il New Yorker affronta il tema dell’integrazione nella società statunitense, la diversità, comunque sia definita, è costruita politicamente e politicamente mantenuta. Non accade “semplicemente”. E’ una scelta che facciamo come società.
Giulia Tomelleri