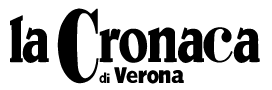Nel 1970 Fabrizio De Andrè pubblicò uno dei suoi album all’epoca più controversi, La buona novella. Basato su fonti apocrife della tradizione cristiana, l’album rappresenta, in realtà, un esercizio di critica sociale e culturale rivolta da De Andrè al suo tempo. Come lo stesso cantautore raccontava, la stessa idea dell’album fu accolta con diffidenza: in un’epoca come gli anni Sessanta in cui le strutture del potere erano costantemente oggetto di attacchi cruenti e una nuova cultura tendenzialmente contraria ai legacci e alle limitazioni imposte anche, ma non solo, dalla religione e dalla Chiesa, il progetto di un album dedicato alla figura di Gesù non venne compresa.
Lo scopo di De Andrè è però più sottile, e certamente non può essere considerato agiografico: l’artista riteneva Gesù uno dei più grandi rivoluzionari della storia, forse il più grande, ma lo riteneva al contempo un uomo, e nulla più. Il presupposto e il punto di arrivo della Buona novella è, appunto, l’umanità di Cristo, sottolineata con forza: basti considerare che il brano di apertura è Laudate Dominum, e il brando di chiusura si intitola Laudate Hominem.
Le canzoni sono da molti punti di vista contrarie al senso comune di chiunque sia stato cresciuto nella narrativa cristiana, quindi, di fatto, della maggior parte degli italiani. Il brano Tre madri, ad esempio, mette in luce in egual misura le voci addolorate delle madri dei tre condannati alla crocifissione: a essere ucciso non fu infatti solo Cristo, ma anche i due celebri “ladroni” al suo fianco, e le madri di questi ultimi, in un afflato di grande pathos, si rivolgono a Maria chiedendole di lasciar loro spazio di dolore, visto che a differenza del suo i loro figli non risorgeranno il terzo giorno. E tuttavia, la stessa Maria conclude la canzone con una frase scandalosa: «non fossi stato figlio di Dio, t’avrei ancora per figlio mio».
La frase genera, appunto, scandalo, ossia scuote nel profondo non solo, e non tanto, l’immagine divina di Cristo, ma la stessa figura di Maria, presentata solitamente come immacolata e intatta madre terrena di Gesù, assurta in cielo e che si dà certo al dolore alla morte del figlio, ma che mai ne contesta la missione.
Ma la canzone forse più famosa e più cruda è Il testamento di Tito, il cosiddetto ladrone buono. Ripercorrendo i dieci comandamenti, Tito rivolge una critica contro l’ipocrisia di una società che, basandosi su una morale fasulla rappresentata appunto dai comandamenti, reprime comportamenti divergenti abbracciandoli in realtà nascostamente.
Il verso che però colpisce più di tutti, anche per la sua natura, ancora, scandalosa, controintuitiva, che coglie di sorpresa, è relativa al secondo comandamento, il rifiuto di pronunciare il nome di Dio invano.
Inteso solitamente nel senso proibitivo, tale che esso si traduce nel divieto della blasfemia, questo precetto viene rovesciato da Tito: sulla croce, ferito e in pena, il ladro ha invocato Dio, il quale però non ha offerto risposta: «forse era stanco, forse troppo lontano: davvero lo nominai invano».
EffeEmme