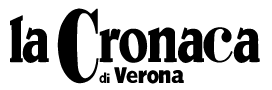Conti i giorni, le ore, i minuti. Ti muovi (quando ti muovi), quasi guardandoti intorno, per vedere se riesci a scoprire il “nemico”. Può essere dappertutto, non ti puoi fidare di nessuno. “Si entra uno alla volta”, dappertutto. E se qualcuno si avvicina a meno di un metro, ti allontani. Istintivamente. Immediatamente. “E’ come in guerra” dicono quelli che la guerra l’hanno vista. “Solo che là, almeno, il nemico lo vedevi, lo conoscevi. Qui è peggio, qui è invisibile”. E l’attesa fa male. La paura dell’abbraccio fa male. La mancanza di contatti fa male. Non è una vacanza, dove al massimo ti annoi ed è bello pure annoiarti perché sai che poi finirà e quella noia ti mancherà. Qui non riesci neppure ad annoiarti, perché hai quella sensazione di incertezza che ti pesa. L’inquietudine come compagna di viaggio. E ti chiedi “come può essere successo, tutto questo?”. E ti domandi perché, nel momento “non ci sono posti letto sufficienti”, “ci sono stati troppi tagli in passato”, “non s’è tenuto conto delle avvisaglie degli scienziati che avvertivano del pericolo di qualche epidemia”. Poi ti accorgi in realtà che adesso “non è il momento adatto, per pensare a questo”. Lo dicono tutti. Questo è il momento di soffrire. Di “pensare da squadra”. Di crederci. Di avere speranza. Proviamoci.