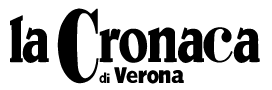Raffaele Tomelleri
“Vai al campo e segui l’allenamento. Se riesci, portami un bel Bagnoli…”. Tradotto, “fagli una bella intervista”. Il campo, ovviamente, era lo stadio. Una volta, non proprio un secolo fa (ma sembrane siano passati due…) andavi “al campo” e potevi parlare con tutti. Prima o dopo l’allenamento. Senza filtri. Senza intoppi. Con educazione, sicuro. Ma senza dover passare da uffici stampa un po’ troppo rigorosi. Andavi, chiedevi al giocatore o al mister, a volte ti dicevano “…facciamo dopo l’allenamento?”, ma era tutto molto più semplice. Più bello. Più vero. Spesso, ci diventavi amico, di quel giocatore. Perchè ti guardavi in faccia, a volte parlavi anche di cose “extracalcio”, sempre avevi mille storie da raccontare. Emozioni, soprattutto. Quelle che piacciono alla gente e ti fanno capire che prima del giocatore c’è un uomo, un ragazzo, i suoi perchè, i suoi come, quando, dove…
Poi, poteva succedere (come quel giorno), che Bagnoli ti dicesse, rientrando dall’allenamento, dopo aver attraversato (a piedi, in mezzo alla bancarelle del mercato, ma ci pensate?) la strada che dall’antistadio porta agli spogliatoi: “Senti, se parliamo mentre faccio la doccia, ti dispiace? Così, guadagniamo tempo…”. E allora, entravi in spogliatoio con lui, ti sedevi sulla panchina e mentre si spogliava e poi si rivestiva, ti raccontava. Più una confessione che un’intervista. Ti diceva di Elkjaer e di Nanu, di Sacchetti e di Bruni (“…mi ci rivedo, in lui”), di Tricella e Fontolan e poi del Volpe (“…uno che ogni allenatore vorrebbe”). E via di mille altre cose, come venivano, come gli sembrava. Tu uscivi e il pezzo era già fatto, dentro c’erano emozioni, verità, semplicità, che nessuna “intervista di plastica” (quelle di oggi…) conterrà mai. E lo stesso, succedeva con i giocatori, quando uscivano e si fermavano lì, a parlare appoggiati alla macchina. Tra un autografo e l’altro. No, niente foto e niente selfie, per fortuna non erano ancora nati. Ma i tifosi c’erano, anche allora. Con foglietto, sciarpa, qualche rara maglia e relativo pennarello per la firma.
Il Dige, il Nanu, Elkjaer, metteteci chi volete, ti raccontava e si raccontava, firmando, con semplicità. Erano i “campioni di tutti”, gl idoli senza piedestallo. Uomini, prima che giocatori.
Poi, quel tempo è finito, come finiscono (quasi sempre) anche le cose più belle. Siamo andati avanti (almeno lo pensiamo), ma siamo tornati indietro. Abbiamo conquistato software e giga e abbiamo perso umanità. Oggi non raccontiamo più l’uomo che c’è dentro l’allenatore, il giocatore. Non ci riusciamo più. Oggi, quando hai un’idea, quando vuoi raccontare alla gente chi è Zaccagni o cosa pensa davvero Aglietti, devi (prima) chiedere il permesso. E poi, forse, ce la puoi fare. Magari in quelle “interviste di plastica”, col backdrop alle spalle, centinaia di sponsor che passano, l’acqua minerale sul tavolo, le domande (tutte uguali) che fioccano, le risposte (tutte uguali) che arrivano. Non c’è emozione, non ci può essere e non è colpa di nessuno. Dei giornalisti, che vorrebbero fare domande diverse. Ma neanche dei protagonisti, che vorrebbero risposte diverse. Non c’è spazio per andare a fondo. Tutto in superficie. Banale e scontato, se volete, inutile. Vuoto. E’ finito quel giornalismo, purtroppo. Ma quel che è peggio, è finito quel calcio. E, peggio ancora, non tornerà più. Peccato.