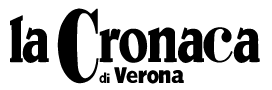Dici Mia Martini ed è, prima che immagine, voce. Come se tutto il resto sparisse e restasse solo il suono. La voce. La sua. Inconfondibile, inarrivabile. E non per le qualità tecniche o l’estensione vocale, che pure c’erano, ma per quello che raccontava, per quello che “tradiva” al di là delle parole cantate. Per le crepe dell’anima che la voce mostrava.
Dici Mia Martini e pensi ad altre voci che per “crepe dell’anima” erano simili alla sua. Pensi alla voce di Edith Piaf, alla voce di Nina Simone, a quella di Billie Holiday. Voci inconfondibili. Voci con i graffi. Voci rigorosamente celate da pseudonimi scelti ad arte. A segnare quasi una distanza tra ciò che erano e ciò che avrebbero voluto essere.
“Mia” come Mia Farrow, attrice che lei adorava, “Martini” come uno dei simboli dell’Italia nel mondo, il Martini. Fu l’Avvocato Alberigo Crocetta, già scopritore di altri talenti, a sceglierlo come cognome d’arte. Fu così che nacque Mia Martini, per tutti semplicemente Mimì.
12 maggio 1995: Loredana Bertè, la sorella minore, riceve delle telefonate da Mia, ma non risponde. “Rimarrò per sempre con il dubbio di avere perso la telefonata più importante della mia vita” dichiarerà anni più tardi. La Procura di Busto Arsizio che dispone l’autopsia, stabilisce infatti che la morte per arresto cardiocircolatorio è avvenuta in quella data, sebbene la morte di Mia Martini venga scoperta solo il 14 maggio.
La solitudine e una maledetta diceria. È questa profonda solitudine la cifra del suo vissuto. Un’infanzia turbolenta, segnata da un padre violento. I primi veri successi negli anni ’70, gli anni di “Piccolo Uomo” e “Minuetto” con i quali vince due volte il Festivalbar. I riconoscimenti della critica europea, che la premia nel 1974 come cantante dell’anno, la collaborazione con Charles Aznavour, il concerto all’Opera di Parigi del ’77. Eppure è in quegli stessi anni che iniziano a circolare, prima per ripicca e invidia di un impresario rifiutato, poi per becera stupidità, le dicerie sul suo conto, l’accusa infamante di “portare jella”. Partita come un sussurro e poi alimentata dalla ripetizione, dalle frasi a metà, dai gesti scaramantici quando lei entrava in un luogo, l’accusa si trasformò ben presto in una condanna dalla quale Mia Martini non riuscì mai a liberarsi davvero.
Un unico grande amore. L’amore smisurato e altrettanto tormentato con Ivano Fossati, dal ’77 all’83, del quale canta in maniera quasi profetica “E non finisce mica il cielo”. Canzone che le vale il premio della critica al Sanremo dell’82, premio istituito appositamente per lei. La rinascita avviene al Sanremo dell’89 con “Almeno tu nell’Universo”. Il brano che Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio hanno scritto nel 1972, già proposto a Paola Turci e a un allora sconosciuta Mietta, entrambe in gara nello stesso anno, ma che Lauzi vuole fortemente sia cantato per la prima volta proprio da Mimì. Ed è un trionfo.
Non potrebbe essere altrimenti. Perché Mia Martini aveva il potere di cantare una cosa e di farla percepire come il suo esatto contrario. “E non finisce mica il cielo”, e invece sai che è proprio così. “Gli uomini non cambiano” e senti già che poi in fondo ti dirà il contrario. “Tu, tu che sei diverso” che pare più una supplica che un’affermazione convinta. Le fuoriusciva questa voce ed era come un bicchiere troppo colmo di rabbia e di tristezza vinto da una goccia di troppo. Perché la gente è matta ma è soprattutto molto insoddisfatta.
Dici Mia Martini ed è, prima che immagine, voce. Giulia Tomelleri