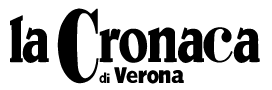Un dissidente rinchiuso nel suo castello dorato è il Gabriele D’Annunzio ritratto in Il Cattivo Poeta, film d’esordio di Gianluca Jodice che racconta l’inquieta quotidianità del Vate tra il 1936 e il 1938, anno della sua morte. Auto-esiliatosi con la sua scarna corte di fedeli presso il Vittoriale degli Italiani dopo la disfatta di Fiume, il Poeta passa il suo ultimo decennio in un continuo tira e molla con il regime; quando nel 1936 l’oppressione del libero pensiero diventa quotidiana routine, il numero due del regime Achille Starace convoca Giovanni Comini, neo-federale di Brescia, per affidargli il compito di sorvegliare il poeta in tutte le sue attività. Il giovin fascista dalle belle speranze si reca dunque al Vittoriale sotto copertura e si avvicina al Vate. Sarà proprio il suo punto di vista a guidare lo spettatore in quest’odissea dannunziana.
Nella scelta di creare una crasi tra la prospettiva del fervente fascista e quella dell’anziano poeta sta in verità tutta l’intelligenza del film di Jodice. Grazie a un’attenta documentazione storica e a una cura maniacale per la scrittura dei dialoghi – che spesso citano proprio le pagine del Sommo -, Il Cattivo Poeta trasforma la parabola del D’Annunzio decadente in un memento sull’importanza del dissenso, sul valore che una resistenza instancabile e giusta può avere anche e soprattutto quando incompresa dai più. Se infatti noi, come il giovane Comini, restiamo straniati di fronte agli eccessi di questo strano figuro dipendente dalla cocaina e dalle donne, avvicinandoci all’uomo-intellettuale e imparando a «leggere» la realtà come «segno», scopriremo l’umanità tormentata di un D’Annunzio – col volto di un Sergio Castellitto calvo e cadente – che non ha nulla a che vedere con lo stereotipo tramandatoci scolasticamente. La sua vita dissennata non è più elogio del piacere per sé, ma deriva estrema di una disillusione politica e personale impossibile da sanare; il desiderio ossessivo di parlare con Mussolini per un ultimo monito prima dell’ecatombe nazista non è un modo per riguadagnare lustro, ma un tentativo disperato di salvare un popolo che – lui, veggente, l’aveva previsto – si stava dirigendo a grandi passi verso la devastazione. La sua lucidità è tanto solida quanto folli sono i suoi gesti e i suoi movimenti, che anche visivamente scardinano un rigido sistema di scene costruite su geometrie perfette, puntualmente rotte dall’apparizione della sua figura: poco più di ombra la sua, ma carismatica, ingombrante e ritta fino alla fine, ultimo baluardo di quella verità che risiede nell’intimo dei grandi Maestri e che, se trasmessa, è capace di lasciare ai posteri ben più che mere, caduche parole.
Maria Letizia Cilea