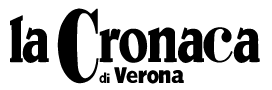Chi vive di cinema sa perfettamente che il potente mix di emozioni trasmesso dal film allo spettatore scaturisce, per un verso, da una componente puramente oggettiva, legata alla qualità intrinseca della pellicola, nelle forme o nella sostanza; per l’altro, al contrario, da un elemento completamente e inevitabilmente soggettivo, connesso alle sensazioni provate sulla propria pelle e in prima persona. Come ci parla quell’opera per via diretta o indiretta? Quali corde dell’anima ha saputo toccare il regista per spingerci ad immedesimarci con questo o quel personaggio?
Per la natura assolutamente personale, la risposta a questa domanda non può essere chiara, definita e certa; anzi, molto spesso, noi per primi non siamo in grado di comprenderne il perché, ma ci lasciamo ugualmente cullare o travolgere dalle immagini, dalla musica, dai dialoghi e dalle espressività degli attori. Sono i momenti più belli, quelli in cui abbiamo reale percezione della scintilla divina che risiede nell’essere umano; quelli in cui la sensibilità, caratteristica tutta nostra all’interno del mondo animale, raggiunge le vette più elevate e pure.
Sulla base di questo meccanismo, due sequenze, per chi scrive, hanno rappresentato da sempre e in modo stranamente simile (ma nemmeno troppo, a ben pensarci), un momento denso di poeticità e pathos.
Da un lato, la scena che si svolge al ristorante ne “Il matrimonio del mio migliore amico” di P.J. Hogan; dall’altro quella presso il banchetto nuziale in “Buongiorno notte” del nostro Marco Bellocchio. Due opere e due vicende distanti sotto ogni profilo, ma in grado, per il processo illustrato, di consegnare, in quei cinque minuti, identici messaggi e identici stimoli di riflessione.
Grazie a un’analisi dettagliata si nota come venga facile stabilire un parallelismo fra quei momenti e quanto numerose siano le componenti che li accomunano. A cominciare dall’”improvvisazione” corale dei membri del cast. Immergendoci nella storia, infatti, le canzoni arrivano spontanee e cariche di significati, ma soprattutto divengono funzionali per l’innalzamento di una sorta di barriera fra i protagonisti dei film e i differenti contesti che li circondano; il clima è festoso, quasi gioioso eppure da una parte Julia Roberts e Michael O’Neal sulle note di “I Say a Little Prayer”, dall’altra Maya Sansa sui versi di “Fischia il vento” vivono sensazioni assolutamente spiacevoli e quasi sgradevoli. È sicuramente questo contrasto a rendere tanto affascinante quegli attimi di vita vissuta. Il disagio di ritrovarsi in situazioni che vengono percepite come estranee, una rivelazione improvvisamente conquistata, una consapevolezza profonda e potente sul senso della propria esistenza. Comprendere, cioè, che la quotidianità di ciascuno di noi è dominata da luoghi comuni o schemi di pensiero in cui ci sforziamo di credere, ma che la realtà è ben diversa: più semplice, più immediata, maggiormente primordiale.
L’interiorità detta, il cinema dipinge.
Matteo Quaglia