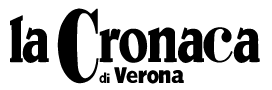C’era poesia, allora.
Tu andavi al campo, li aspettavi, ci potevi parlare tutti i giorni, con i giocatori. Nascevano rapporti veri. Parlavi di tutto, forse più di altro che di calcio. I figli. La famiglia. I pensieri. I sorrisi. Ci stavi assieme delle mezz’ore buone, magari appoggiati lì, a qualche macchina del parcheggio. Non c’erano gli uffici stampa, allora. Diventavi spesso amico, loro si fidavano di te e tu non li tradivi. Ti raccontavano tutto, del mister “che non mi vede”, oppure “che non mi doveva cambiare”. C’era talmente confidenza che spesso ti facevano entrare in spogliatoio. Mentre facevano la doccia. O durante i massaggi. Ti sedevi sulla panchina, eri uno di loro.
C’era semplicità, allora. Tu andavi al campo e c’erano porte aperte, in tutti i sensi. Era bello lavorare così. Potevi raccontare alla gente emozioni, non solo “diagonali” e schemi, non se ne parlava neppure. Ti sembrava di fare davvero il lavoro più bello del mondo. Parlavi con loro e trasmettevi pensieri, sospiri, brividi, a chi ti leggeva. Non solo calcio, macchè. Quello che c’è prima, quello che c’è dopo. La strada che devi fare per arrivare, le fatiche, spesso anche le lacrime. E la paura di non farcela. Ad arrivare. A restarci. A non scendere. Mica come oggi, con interviste “di plastica”, loro seduti ad ascoltare domande per forza di cose banali e a dare risposte ancora più banali. “Andremo là a dare il massimo”, oppure, “faremo la nostra partita”, o ancora, “le partite si decidono per episodi”. Già, senti la novità…
C’era normalità, allora. Erano campioni, magari anche campionissimi, ma li avvertivi vicini, ragazzi come te, compagni di viaggio che avevano il piacere di camminare con te. E di raccontarsi. A te, alla gente, ai tifosi, ai lettori. E la società faceva di tutto per avvicinarli, per non creare filri, barriere, ostacoli. Eravamo sulla stessa barca, allora e ci stavi pure bene. Due facce della stessa medaglia, loro bravi a raccontarsi (in partita e fuori) e tu dovevi essere bravo a “tradurli”. Ma ti veniva facile.
C’era umanità, allora. Nessuno aveva ancora detto loro che prima di parlare devono dirlo all’ufficio stampa, che magari parla col direttore sportivo, che poi, forse (se gli gira), concede l’ok. Nessuno aveva ancora detto loro che prima di parlare con un giornalista ci dev’essere il “visto” della società. Come se ci fossero segreti di stato. Come se il calcio fosse improvvisamente cambiato. Come se non stessimo raccontando piccole o grandi storie di vita che nascono intorno a un pallone, o dentro uno spogliatoio. Con semplicità, sincerità, amicizia, passione. Nessuno ha mai spiegato loro che un’intervista mancata è un’occasione persa. E che così finisce (tranquilli, è già finita) la poesia dello sport.